| Commento all’articolo:
L’uomo e la natura di don Gianni Baget Bozzo |
Nell’intervista del 12 dicembre 1968 a Manlio Cancogni, discorrendo sulla fine del mondo, Montale propone iperbolicamente la «guerra» come soluzione finale alla condizione in cui è ridotta la società: una guerra cosmica e (forse) nucleare, che possa ricondurre allo stadio primitivo della vita. Sorge quasi spontaneo pensare che alluda indirettamente alle pagine finali de “La Coscienza di Zeno” – da lui stesso ricordate nel saggio del 1925, “Omaggio a Italo Svevo”, come «felicissime» – nelle quali un’esplosione potrà forse ricondurre il pianeta alla «salute»: “Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. […] Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.
L’Apocalisse e la fine del mondo sono, nella produzione montaliana senile, due leitmotiv destinati a perdurare fino agli estremi Altri versi. Come ha scritto Claudio Marabini, ricordando Montale durante la consegna del premio Elba con “Fuori di casa”, la produzione del poeta ha sempre girato intorno alla ben nota e affezionata immagine dell’apocalisse: il mondo alla soglia dell’ignoto e della distruzione, l’uomo sul punto d’essere liquidato, i valori tradizionali ormai compromessi, anzi, distrutti, nulla di prevedibile ma tutto affidato al caso, arti comprese, del resto ormai mercificate, eccetera. Già in “Satura” del ’71 le prime avvisaglie di un possibile scoppio planetario cominciavano a palesarsi:
La crosta del mondo si chiude, com’era prevedibile
se prelude a uno scoppio. Era improbabile
anche l’uomo, si afferma. Per la consolazione
di non so chi, lassù alla lotteria
è stato estratto il numero che non usciva mai.
Ma non ci sarà scoppio. Basta il peggio
che è infinito per natura mentre
il meglio dura poco.
Già lo ricordava Henry David Thoreau in “Dobbiamo essere al timone almeno una volta al giorno”, “L’intero giorno non deve essere diurno, né la notte notturna, ma una parte deve essere salvata, di tanto in tanto. Tutte le nostre ore non devono essere correnti; tutto il nostro tempo non deve scadere. Ci deve essere almeno un’ora che il giorno non ha fatto nascere, di antica discendenza e nobiltà consolidata, che sarà una piattaforma serena e alta che sovrasta il resto. Dovremmo fare ogni giorno il punto sui nostri personaggi, come Robinson Crusoe sul suo bastone. Dobbiamo essere al timone almeno una volta al giorno; dobbiamo sentire la barra del timone nelle nostre mani e sapere che se navighiamo, governiamo…”.
Vent’anni fa, il 26 dicembre 2004 avvenne uno dei disastri naturali maggiormente catastrofici dell’epoca contemporanea, che causò oltre 230.000 morti. Un terremoto e un successivo maremoto distrussero varie zone della costa asiatica. Il cinema raccontò quell’evento con il film The Impossible di Juan Antonio Bayona, dalla lente d’ingrandimento di una famiglia che si trovava in vacanza proprio in quella zona del sud-est asiatico. Il film di Bayona è basato sulla vera storia di una famiglia sopravvissuta a questo disastro che colpì l’Oceano Indiano. Maria, Henry e i loro tre figli sono in vacanza durante le festività natalizie in Thailandia. La loro vita viene sconvolta quando un’enorme ondata travolge il loro resort, separandoli l’uno dall’altro. Don Gianni parlava già di interazione con la tecnologia. Qualche fanatico animalista – più di uno, per la verità – vide la foto del regista Steven Spielberg seduto sulla carcassa del dinosauro: pensò che il bestione fosse ancora palpitante, appena abbattuto da un cacciatore cattivo, e partì lo shitstorm. La maggior parte dei twittaroli per fortuna capì che il mostro era meccanico, in gomma e ingranaggi, e cominciò a sfottere gli altri. Possiamo solo immaginare quanti guasti l’intelligenza artificiale produrrà nello scontro con la credulità naturale, nel settore “documentari”.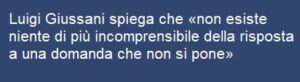
I neri con le divise naziste, e gli alti gradi, sono già su internet: ma un conto è trovare fotomontaggi in rete, dove sappiamo che esiste ogni cosa e il contrario di tutto, fino ai deepfake. Un conto sarebbe vederli in un documentario, che per statuto rende conto di fatti e di persone reali (per quelle inventate, e le creature fantastiche, c’è il cinema). Lo fa usando riprese dal vero e documenti d’archivio.
Questa è la regola. Ma già i documentari sulla natura di Walt Disney, tipo “Il deserto che vive”, non erano solo una macchina da presa puntata sullo scorpione e la sua preda. Per la ripresa giusta ci volevano ore di appostamento, e un bel lavoro di montaggio. Quando il leone insegue e mangia la gazzella, non si preoccupa dei campi/controcampi a effetto.
I registi e gli sceneggiatori temono l’intelligenza artificiale, per questo hanno a lungo scioperato. I documentaristi sono più preoccupati: il cinema è finzione, il documentario dovrebbe riprodurre la realtà. Al festival di Camden si sono riuniti per definire le linee guida. Dicono: non vogliamo rifiutare le possibilità di una tecnologia che sta modificando tutte le forme di storytelling visivo. Vogliamo però riaffermare i valori giornalistici che la comunità dei documentaristi ha sempre rispettato.
Citando il teologo protestante Niebuhr, Monsignor Luigi Giussani spiega che «non esiste niente di più incomprensibile della risposta a una domanda che non si pone». E’ uno dei problemi della nostra cultura da supermercato – che presenta offerte alla portata di tutti per tranquillizzare il cuore – è il dare voce a queste domande del cuore. Questa è la sfida. Di fronte al torpore della vita, a una tranquillità offerta a poco prezzo da una cultura da supermarket (anche se estremamente variata nelle sue forme), la sfida consiste nel rivolgere a noi stessi i veri interrogativi riguardo al significato dell’uomo, alla nostra esistenza, e nel dare risposta a queste domande. Ma se vogliamo rispondere a domande alle quali non osiamo o non sappiamo rispondere, o non riusciamo a formulare, cadiamo in un assurdo.
Per un uomo che abbia dimenticato o censurato i suoi “perché” fondamentali e l’ardente anelito del suo cuore, il fatto di parlargli di Dio risulta un discorso astratto, esoterico o una spinta a una devozione senza nessuna incidenza sulla vita. Non si può iniziare un discorso su Dio, se prima non vengono soffiate via le ceneri che soffocano la brace ardente delle domande fondamentali. Il primo passo è trovare il senso di tali domande che sono nascoste, sotterrate, forse quasi morenti, ma che esistono. A sua volta la fede è, precisamente, un’applicazione particolare del metodo della certezza morale o esistenziale, un caso particolare di fiducia nell’altro, nei segni, negli indizi, nelle convergenze, nella testimonianza di altri. Nonostante ciò, la fede non è contraria alla ragione. Come tutti gli atti tipicamente umani, la fede è ragionevole, cosa che non implica che possa ridursi a un mero raziocinio. È ragionevole – forziamo l’espressione –, ma non raziocinante.
Davide Fent
Altri commenti:
Breve storia di una lunga incomprensione di Fabio Campinoti
La solitudine dell’uomo di Alessandro Gianmoena
Il Sacro e il Santo. Note sull’origine del senso religioso e il destino dell’uomo di Davide Penna
La natura e la tecnica di Simone Vaccaro
